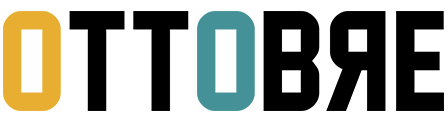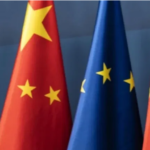Nel silenzio generale, e in avanzato stato di segretezza, procedono i negoziati del Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti (TTIP), l’accordo che l’Unione Europea sta negoziando con gli Stati Uniti dal luglio 2013, quando Barack Obama e l’allora presidente della Commissione José Manuel Barroso, dopo più di dieci anni di preparazione, avviarono ufficialmente i negoziati, oggi portati avanti dal commissario UE per il commercio Cecila Mallström.
Nelle nobili intenzioni dei passacarte della borghesia che siedono a Bruxelles e Washington la fase negoziale doveva chiudersi a fine 2015: l’unica buona notizia è che sono un po’ in ritardo. Obiettivo: la creazione di una zona di libero scambio che includa i due continenti più sviluppati, in cui risiede il 45% del PIL mondiale.
I dettagli dei negoziati sono segreti, le discussioni intercorrono a porte chiuse tra rappresentanti delle varie branche di settore, le lobbies industriali e i funzionari UE. Il mandato dei negoziati non proviene da nessuna investitura democratico/consultativa, ma più genericamente, dagli Stati membri, per ammissione dello stesso Commissario europeo.
Ci si deve dunque accontentare di qualche generica frase buona per tutte le stagioni e assolutamente condivisibile nella sua genericità del tipo: “Il TTIP dovrebbe eliminare le tariffe doganali, ridurre la burocrazia e diminuire le restrizioni agli investimenti. Per le imprese dell’UE, piccole e grandi, questo faciliterebbe l’esportazione di beni e servizi negli USA e renderebbe più semplice investire sull’altra sponda dell’Atlantico. Ciò varrebbe, ovviamente, anche per le imprese degli USA che vogliono esportare o investire in Europa.”
Ovviamente questi cantori del Trattato sono gli stessi che negli anni ‘90 esaltavano le magnifiche sorti e progressive della globalizzazione capitalistica – prima tappa dell’unificazione dei mercati. Promisero all’epoca i miracolosi benefici che l’abbattimento di ostacoli e barriere avrebbero apportato all’economia mondiale.
La tesi, in particolare per quanto riguarda le presunte ricadute sulla crescita dell’economia – astraendo beninteso “l’economia” dalla sua natura di classe – era che i benefici sarebbero ricaduti sulla società tutta intera. Argomentazione oggi riproposta a giustificazione della necessità del TTIP e riassumibile così: “siccome c’è la crisi permanente, allora continuiamo con le ricette che arricchiscono le grandi aziende, vi assicuriamo che qualche briciola ricadrà pure su di voi”.
Per quanto riguarda l’occupazione, la presentazione del TTIP afferma: “L’effetto per l’economia europea sarebbe positivo e contribuirebbe a creare nuovi posti di lavoro. Nell’UE vi sono già 30 milioni di posti di lavoro che dipendono dalle esportazioni e le imprese statunitensi danno lavoro nell’Unione a 3,5 milioni di persone.”
Ora, sarebbe fin troppo facile affermare, prove alla mano, che queste previsioni non si sono mai avverate e che insistere nel proporre soluzioni rivelatesi sbagliate è da stolti. Diversamente da quello che si vorrebbe far credere, i nostri governanti non sono degli sprovveduti, essi al contrario sanno quel che fanno e rispondono a un agenda ben precisa, quella della borghesia, del mondo degli affari. E dunque realizzano col TTIP la classica operazione atta a favorire i grandi gruppi, sulla linea di tutte le macro-misure di politica economica intraprese dagli anni 80 in poi: ovvero rimpinguare i dividendi degli azionisti, per cercare di controbilanciare la tendenza alla caduta dei profitti a discapito del lavoro.
Tuttavia per zittire le critiche al TTIP sollevate dalle sinistre i nostri governanti dicono oggi all’opinione pubblica: “Se funzionano le aziende si crea lavoro, quindi perché opporsi a una misura che aiuterebbe l’insieme dell’attività economica?”. Teoria falsificata dacché è facile vedere oggi quanti licenziamenti covavano sotto le ceneri del Capitale globalizzato. E la ragione è più che semplice, per chi vuol vederla: in un sistema produttivo basato sull’accumulazione e il profitto privato, l’estensione degli accordi di libero scambio invece di aumentare il lavoro aumenta in realtà lo sfruttamento del lavoro, e le uniche imprese in grado di sfruttare il lavoro su larga scala sono i collossi industrial-finanziari, in prima linea nei negoziati.
Lo confermano i dati, i quali registrano sistematicamente come alla crescita del fatturato e della redditività delle aziende non corrisponda affatto una crescita equivalente dei posti di lavoro. Questo non è affatto un mistero: l’automazione, l’informatizzazione, la possibilità di localizzare la produzione nel terzo mondo, tutti questi fattori non consentono di credere alla favola dei “posti di lavoro in più” in Europa e USA.
Inoltre i pochi posti di lavoro che verranno eventualmente creati saranno comunque precari, in Italia ad esempio sotto il Jobs Act, e sottomessi alla dittatura della nuova congiuntura, ovvero spazzati via col pretesto dalla prossima crisi.
Per i lavoratori vale dunque l’insegnamento della globalizzazione e dell’unificazione del mercato europeo: quanto più si allarga la base degli affari delle multinazionali, e si ingigantisce il loro campo d’azione, quanto meno le aziende hanno bisogno di personale, poiché procedono per gradi di acquisizioni atte a razionalizzare le strutture del personale, ovvero liquidare le posizioni doppione nella nuova entità risultante da fusioni e acquisizioni. Questa dinamica aumenta automaticamente la disoccupazione, lo sfruttamento delle risorse umane restanti, diminuendo per altro le prospettive di impiego future.
Solo così il sistema può produrre quell’eccedente capace di rimborsare prestiti bancari contratti dalle imprese, versare dividendi agli azionisti, e garantire profitti in grado di riprodurre il ciclo economico. In un modo capitalistico di produzione non può essere altrimenti: gli investimenti tecnologici fanno esplodere la produttività, e sono funzionali al taglio del monte stipendi a medio-lungo termine; questo è l’unica redditività-sul-capitale-investito che conti per una società privata.
Ideologia del “libero mercato”
L’impostazione del TTIP, la sua filosofia di base come i suoi referenti e sponsor, risulta in definitiva dal capitalismo in salsa neo-liberista impostosi con sempre più vigore dagli anni ’80 e che la caduta dell’URSS ha favorito. Si articola per concludere intorno a tre pilastri:
1) Preminenza delle istituzioni tecniche e sovranazionali, che elaborano ricette “perfette” slegate dai contesti nazionali, storici e culturali: si tratta del paradigma della “naturalità” del liberismo, come vera e unica dottrina, incarnata nel FMI, BCE, UE etc.
2) Multinazionali come autentiche depositarie dell’interesse generale, poiché coinvolgono nel loro processo di produzione l’insieme degli attori sociali. Il compito della politica è di non intralciare il loro operato con regole “assurde” – in particolare tutte quelle che regolano i rapporti di lavoro – ma favorire il libero sviluppo degli affari, promuovere prioritariamente i diritti degli investitori, ovvero i diritti di una ultra-minoranza di privilegiati. Si da così sempre piu preponderanza agli interessi privati in quanto regolatori della vita sociale: alla società non resta che rimettersi alle decisioni illuminate dei geni che siedono nei consigli di amministrazione dei grandi gruppi.
3) Deregolamentazione della circolazione di merci e capitali. Non per nulla il TTIP è accompagnato dal recente progetto di unificazione del “libero mercato” dei capitali europeo, previsto per il 2019, per coronare il processo di restaurazione borghese internazionale.
Il controllo democratico, già arduo nella società capitalista su scala nazionale, diventa una pura illusione nel contesto della dimensione transnazionale del libero mercato degli affari, che il TTIP consolida. Per i lavoratori, si tratta purtroppo dell’ennesima catena cinta intorno alle loro speranze di emancipazione sociale.
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_it.htm
http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/
https://mauropoggi.wordpress.com/2016/02/01/ttip-la-dirittura-darrivo/